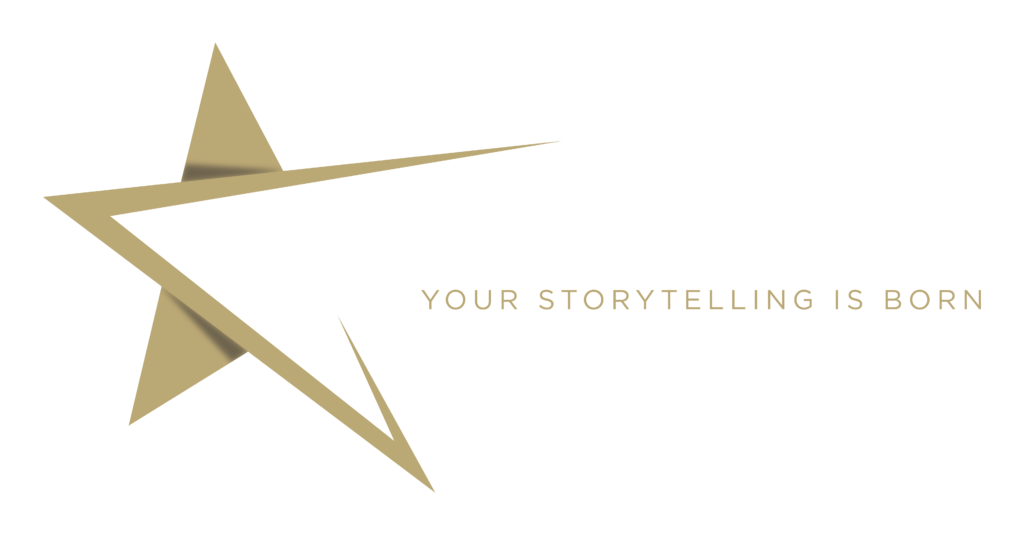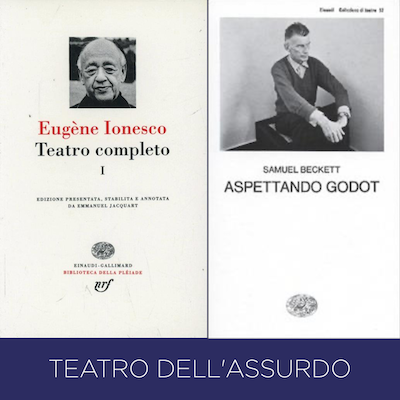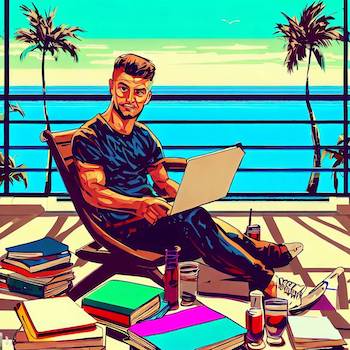Elementi di base
Il manifesto dadaista è del 1918 ed è scritto da Tristan Tzara (1896, Moinesti – Romania – 1963, Parigi).
Il termine Dada appare per la prima volta sulla rivista “Cabaret Voltaire” il 15 giugno del 1916. Questa parola non significa assolutamente nulla, è coniata da un gruppo di ventenni ed esprime il loro senso di rivolta contro contro la società. Il movimento nasce a Zurigo, dove si raccolgono giovani esuli di vari paesi, disertori come Ball (il fondatore del cabaret Voltaire, il ritrovo dei dadaisti a Zurigo), rivoluzionari come Lenin (che abita vicino al cabaret Voltaire), intellettuali e profughi. Nel 1920 Dada arriva a Parigi, dove trova l’appoggio di André Breton, che poi fonderà il movimento surrealista. A Parigi si svolgono numerose serate Dada, esposizioni. In America Dada è portato da Man Ray (che in quegli anni si trova a Parigi) e poi Dada si diffonderà anche in Germania. In Germania Dada avrà un carattere più politico, la cui massima espressione saranno i fotomontaggi creati da Jonh Heartefiedl contro il nazismo e Hitler.

Poetica
Dada non è un movimento letterario, una scuola di pittura, un movimento filosofico o politico. Dada rifiuta qualsiasi nozione di arte o di cultura, distinzioni di generi, perché la guerra mondiale (1914 – 1918), ha messo in crisi tutti i valori precedenti che si sono rivelati ipocriti.
Dada è essenzialmente un movimento di ribellione contro la guerra e contro la morale e l’ipocrisia della borghesia che ha condotto i popoli al macello. Dada è quindi un fenomeno di ribellione sociale che si esprime attraverso tutte le forme della comunicazione: dalla pittura al teatro, dalla scultura alla poesia, dalla recitazione all’improvvisazione, dai volantini alle performances. Il filo conduttore di Dada è la provocazione: provocare il pubblico, provocare i “benpensanti” per ottenere una loro reazione. I mezzi utilizzati sono lo “humour” e la “sorpresa”. A una serata Dada il pubblico ride, si innervosisce e non sa mai esattamente cosa succederà.
"Una sola cosa importa: che tale gesto sia sempre una provocazione contro il cosiddetto buon senso, contro la morale, contro le regole, contro la legge; quindi lo scandalo è lo strumento preferito dai dadaisti per esprimersi (...) Questi intellettuali cercavano di comare il vuoto, la disperazione, la nausea che la guerra e il dopoguerra avevano provocato in loro (...) era n modo per sentirsi vivi in un rischio intellettuale continuo". (Mario de Micheli, Le avanguardie artistiche del 900, Feltrinelli, Milano 1966-1981, pag. 156 e 171).
Per discutere
“Dichiaro che Tristan Tzara ha trovato la parola Dada l’8 febbraio 1916 alle sei pomeridiane; ero presente con i miei dodici figli quando Tzara pronunciò per la prima volta questa parola che ci ha riempiti di legittimo entusiasmo. Questo accadeva al caffè Terrasse di Zurigo mentre m’introducevo una brioche nella narice sinistra. Sono convinto che questa parola non ha la minima importanza e che solo gli imbecilli e i professori spagnoli possono interessarsi alle date. Quello che a noi importa è lo spirito Dada, noi eravamo tutti dada prima prima dell’esistenza di DADA.” (Arp).
“Il pensiero si fa nella bocca” (Tristan Tzara).
“I dada considerano le parole come se fossero incidenti e lascia che si verifichino. Si comportano come dei ferrovieri che si disinteressano dei segnali… Il linguaggio di Dada non è un mezzo, è un essere.” (Rivière).
“Se per Dada la sorpresa, che Apollinaire raccomandava come un importante fattore poetico, è diventata scandalo, non è certo perché vuole esaltare un procedimento artistico, ma perché Dada stesso era lo scandalo che si identificava con il suo modo di vivere e di manifestarsi” (Tristan Tzara).
“Di qui il disgusto e la rivolta. Noi eravamo risolutamente contro la guerra, senza perciò cadere nelle facili pieghe del pacifismo utopistico. Noi sapevamo che non si poteva sopprimere la guerra se non estirpandone le radici. L’impazienza di vivere era grande, il disgusto si applicava a tutte le forme della civilizzazione cosiddetta moderna” (Tristan Tzara, alla radio francese, 1950).
“Allorché, nel 1917, Platten ritornò a Zurigo, portandoci da Mosca notizie precise sulla Rivoluzione (…) abbiamo salutato la rivoluzione russa nella misura in cui essa costituiva il solo mezzo capace di mettere un termine alla guerra” (Tristan Tzara).

Specialmente in Germania il Dadaismo prende una connotazione molto politica:
"concludevamo sempre che quest'arte se pretendeva di avere un minimo valore, poteva essere solo un'arma per la lotta di classe. (...) delusi nelle nostre speranze, nella vita, vedevamo la salvezza del mondo solo nell'estrema conseguenza: lotta organizzata del proletariato, conquista del potere. Dittatura. Rivoluzione mondiale. La Russia era il nostro ideale. E questo sentimento era tanto più forte e scrivevamo sulle nostre bandiere dell'arte la parola 'azione' con un colore tanto più rosso, in quanto invece della vittoria sperata ci giungevano una dopo l'altra le notizie delle sconfitte del proletariato. Portammo alla sepoltura Liebknecht (...) e poi Rosa Luxemburg." (Erwin Pscator, regista, dal libro Il teatro politico, 1929, cit. in Mario de Micheli, Le avanguardie artistiche del 900, Feltrinelli, Milano 1966-1981, pag. 169).
Serate Dada
“Le serate dada erano precedute da una sorta di battage pubblicitario che faceva sì che lo spettacolo cominciasse già fuori del luogo teatrale (…). La scelta stessa delle sale rivestiva, agli occhi del pubblico, il carattere di un insulto: per esempio la Salle Gaveau, con il suo apparato di organi e di piani a coda normalmente riservati alle grandi musiche di Bach e di Mozart, fu scelta per la seconda manifestazione dada del 26 maggio 1920. In occasione di questa serata uomini – sandwich girarono per Parigi distribuendo programmi in cui erano stampate frasi come questa: ‘Ciascuno di voi ha nel cuore un contabile, un orologio e un piccolo pacchetto di merda’ o come: ‘DADA è felicità alla coque’. Comunicati stampa annunciarono l’avvenimento in questi termini: ‘Fatto inaudito, tutti i dadaisti si faranno rapare la testa in pubblico. Vi saranno altre attrazioni: pugilato senza dolore, presentazione di un illusionista dada, un avventuriero in carne ed ossa, una grande opera, della musica sodomita, una sinfonia a venti voci, una danza immobile, due commedie, dei manifesti, delle poesie. E finalmente, potremo conoscere il sesso di DADA’.
(…) dice Sanouillet: ‘Ciò che dicevano o facevano i dadaisti sulla scena importava poco. La novità era di poterli apostrofare, di sentirsi rispondere, di ristabilire infine una connivenza teatrale (…) sul podio, dove le altre sere si inchinavano cerimoniosamente, ubbidendo alla bacchetta del direttore d’orchestra, sessanta musicisti in abito da sera, sei dadaisti, vestiti di nero, con il capo nascosto in enormi cilindri di cartone bianco , compivano lugubri evoluzioni…. Immaginando benissimo la natura del divertimento che li aspettava, gli spettatori-complici si riempivano le tasche di munizioni diverse, così come si portano le noccioline americane quando si visita lo zoo. Per tutta la durata dello spettacolo, carote, rape, cavoli, pomodori, e arance andate a male, uova, insieme a monete e a frecce di carta, descrivevano graziose traiettorie fra versi di animali e battute di spirito che si intrecciavano nella sala.’
(…) Davanti a questo pubblico si esibiva Soupault, nelle vesti del ‘celebre illusionista’, in uno sketch semplicissimo ma di indubbia efficacia: mascherato da negro e avvolto in una veste da camera bianca, con un coltello in mano, apriva con gesti solenni una valigia, da cui uscivano cinque palloncini: due rossi, due blu e uno verde su cui erano scritti i nomi di Benedetto XV, di Rachilde, di Clemencau e di Petain. Il quinto, dedicato a Jean Cocteau, veniva squarciato con un gran coltello. Il pubblico, divertitissimo, faceva scoppiare gli altri.
Oppure Paul Eluard, racchiuso in un sacco di tarlatana gialla e con in testa una parrucca di lana, faceva a gara con Breton, in pantaloni rossi, a riversare sul pubblico i dialoghi incoerenti del Vous m’oublierez.” (Teatro Dada, a cura di Gian Renzo Morteo e Ippolito Simonis, Prefazione, Einaudi, 1988, pag. 10-12)
Esposizione in Germania
“L’esposizione di quadri, sculture e oggetti diversi ebbe luogo nel cortile di un caffè centrale. Per accedervi, bisognava attraversare i gabinetti di decenza. All’ingresso una ragazza in costume da prima comunione recitava versi osceni. In mezzo al cortile si alzava un oggetto di legno duro di Ernst, con accanto una scure attaccata a un catena: il pubblico era invitato a impugnare la scure e distruggere la ‘scultura’. In un angolo Baargeld aveva addirittura collocato un acquario, pieno di un liquido rosso come sangue, sul cui fondo ondeggiava una capigliatura femminile. Infine tutt’intorno erano appesi fotomontaggi di carattere sacrilego, scandaloso, sessuale. I visitatori infuriati, a varie riprese, devastarono il locale e sfregiarono le opere, finché le autorità, proibirono la mostra.” (Mario de Micheli, Le avanguardie artistiche del 900, Feltrinelli, Milano, 1966-1981, pag. 168).
Tecnica della poesia dadaista
“Prendete un giornale. Prendete un paio di forbici. Scegliete nel giornale un articolo che abbia la lunghezza che voi desiderate dare alla vostra poesia. Ritagliate l’articolo. Tagliate ancora con cura ogni parola che forma tale articolo e mettete tutte le parole in un sacchetto. Agitate dolcemente. Tirate fuori le prole una dopo l’altra disponendole nell’ordine con cui le estrarrete. Copiatele coscienziosamente. La poesia vi rassomiglierà” (Tristan Tzara, Manifesto sull’amore debole e l’amore amaro, 1920).
Tecnica del fotomontaggio
John Heartefield spediva dal fronte strane cartoline formate da immagini e ritagli di giornali, scritte che servivano per far passare dalle maglie della censura messaggi contro la guerra e di tipo demistificante.
Hausmann, dal canto suo, faceva risalire la sua personale scoperta del fotomontaggio a un soggiorno sul Baltico, durante il quale aveva visto che nelle case era appesa la stessa fotografia di un granatiere sullo sfondo di una caserma, il cui volto originale però, era stato sostituito dal ritaglio della foto del familiare soldato.
Tecnica del collage
La tecnica del collage è stata la grande invenzione dada, un modo per smontare e ricostruire la realtà, facendo assumere di volta in volta connotati astratti, ironici, grotteschi, stupefacenti. Preludio alla confusione della comunicazione nella società dei media, può essere letta come una tecnica che permette di “svelare” il senso della realtà, al di là della sua apparenza Veniva usata anche come tecnica di provocazione. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto dai dadaisti tedeschi.
Approfondisci con i miei eBook
Qui, in Gumroad trovi offerte speciali per i miei libri (che sono in tutti gli store, ma qui li trovi con sconti, gratis e in bundle). Ti segnalo il Bundle che comprende tre libri sul podcasting e puoi vedere anche racconti e romanzi per apprendere lo storytelling, libri di fotografia e di montaggio video, graphic novel, Intelligenza Artificiale, e diversi di questi sono gratuiti! E comunque, in tutti puoi applicare uno sconto del 25% inserendo il codice SCONTO25.
Vuoi avere notizie della qualità di Autore? Leggi questa pagina del mio sito: https://www.albertopian.it/pubblicazioni/Raccontare il "vero"